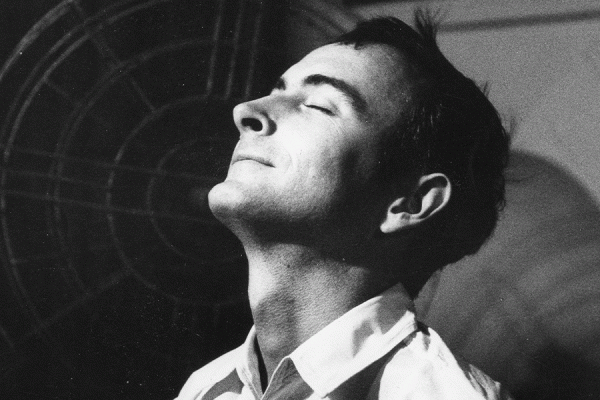Al netto delle solite polemiche sulla faziosità, che non ci interessano in questa sede, possiamo di certo affermare che Michele Santoro è sempre stato un giornalista tanto talentuoso quanto sicuro di sé. Queste due caratteristiche lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera facendone uno dei personaggi più importanti e divisivi dell’informazione italiana, ma ora sono le stesse che rischiano di minare il suo progetto Robinù, un lunghissimo documentario di quasi 100 minuti che racconta la ‘paranza dei bambini’, cioè l’interminabile faida tra babyboss che da due anni sta inondando di giovanissimo sangue le strade di Napoli.
Premettiamo subito che il film, presentato a Venezia nella nuova sezione non competitiva Cinema nel Giardino, è di certo frutto di un lavoro eccellente e offre uno spaccato drammatico e interessantissimo della realtà criminale partenopea, coinvolgendo lo spettatore al punto che, nonostante la considerevole mole di informazioni cui verrà esposto durante la proiezione della pellicola, una volta uscito dalla sala vorrà certamente approfondire.
Detto ciò, va però considerato che il peggior avversario del Santoro regista è il Santoro giornalista televisivo. La formula adottata è infatti molto poco cinematografica e il linguaggio narrativo, affidato interamente alle interviste ai giovani criminali e ai loro parenti, è asciutto ai limiti dell’accettabile. A inficiare però il comunque rispettabile ‘verismo’ di un regista invisibile ci pensano ammiccamenti a volte fastidiosi: dal logotipo perfettamente in continuità con la ‘brand identity’ adottata da Santoro negli ultimi tre lustri, alle scelte musicali che strizzano l’occhio alla Gomorra televisiva di Sky, all’artificiosa ricostruzione del parlato degli interlocutori telefonici.
Se inoltre si decide di diventare narratori invisibili e lasciar parlare solo i protagonisti, si deve accettare di correre il rischio che i discorsi dei baby boss siano la pedissequa riproposizione della medesima banale, agghiacciante retorica. E se per un po’ il gioco della ripetizione funziona e risulta efficacemente perturbante, alla lunga le parole e le storie risultano troppo simili e i 97 minuti di durata finiscono per risultare a dir poco eccessivi.
Il risultato sembra uno straordinario prodotto televisivo riproposto, con una durata sesquipedale e non necessaria, sullo schermo cinematografico. E se Santoro avesse fatto un po’ meno affidamento sul suo comprovato talento di giornalista e sulla sua grande esperienza passata e avesse sfidato se stesso cercando una strada più nuova, di certo avrebbe confezionato un prodotto perfetto.

Venezia 73: la recensione in anteprima di Robinù di Michele Santoro
Il celebre giornalista arriva a Venezia in veste di regista di un documentario sulla babycriminalità napoletana e sulla "paranza dei bambini".