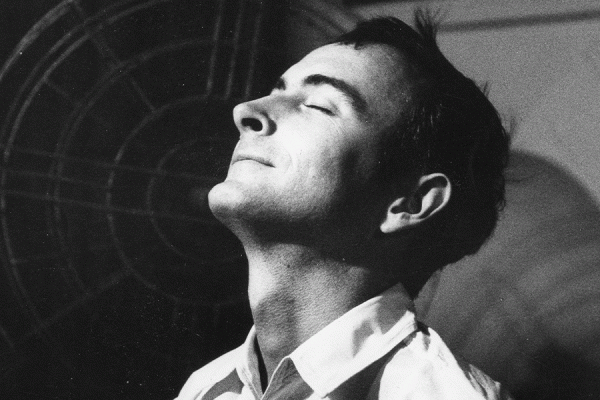Come vi abbiamo già raccontato, questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è aperta all’insegna della musica con la riuscitissima pellicola di Damien Chazelle, quel La la land che non ci stupirebbe né come vincitore del Leone d’Oro né, tra qualche mese, come vincitore di diversi Oscar (siamo pronti a scommetterci).
Il passato da jazzista di Chazelle emerge prepotentemente nel suo ultimo film, in cui un pianista jazz dalle preferenze musicali particolarmente conservatrici (e stereotipate al fine di strizzare l’occhio al grande pubblico) dapprima si ritrova a storcere il naso davanti a sonorità che fanno venire alla mente la seconda parte della brillantissima carriera di Robert Glasper ma poi si ritrova a suonare con un osceno ensemble pop-r’n’b capitanato da John Legend: i Messengers.
Ecco, se quei ‘messaggeri’ facevano tutto fuorché jazz, gli indimenticabili Jazz Messengers di Art Blakey finiscono invece per ricordarci prepotentemente il loro swing in I Called Him Morgan, il meraviglioso documentario di Kasper Collin proiettato ieri nella sezione ‘fuori concorso’ del festival veneziano.
I Called Him Morgan racconta la complicata vita e la scioccante morte del grandissimo trombettista Lee Morgan, e lo fa restituendoci un ritratto appassionato e di grande sincerità – nulla a che vedere con l’idealizzazione mainstream di Chazelle – della scena be bop e hard-bop degli anni ‘60.
La vita di Morgan di certo offre spunti interessanti per una narrazione cinematografica: talento incontenibile sin dalla più tenera età (si avvicinò alla musica col vibrafono e il sax alto per poi dedicarsi completamente alla tromba), fu protagonista di un’ascesa vertiginosa che lo portò prima a diventare secondo trombettista nella band del gigante Dizzy Gillespie e poi presenza fissa nella formazione di Art Blakey, prima di una non trascurabile carriera solistica. Consapevole delle proprie capacità, stimato e amato dai propri colleghi, aveva un vero e proprio culto per l’eleganza e non c’era donna che gli resistesse. Come accadde a molti musicisti di quel periodo – e come succede ancora oggi – presto il sesso, l’alcol e la droga presero il sopravvento e al genio, alla classe e alla professionalità andarono sostituendosi le dipendenze, la trascuratezza e l’inaffidabilità. Una carriera finita, apparentemente, almeno fino a un incontro che riuscirà a restituire a Lee Morgan la sua grandezza, dopo anni di oblio.
Parliamo del momento in cui si incrociarono le strade del trombettista e della futura moglie Helen More, vero fulcro della vita di Morgan e punto focale del documentario di Collin.
Helen era sempre stata una donna tanto problematica quanto indipendente. Caratterizzata da un carattere a dir poco deciso, aveva sempre affrontato l’abbandono (subìto o ricercato) con un improbabile mix tra socievolezza e spiazzante franchezza. Una donna popolare per le sue feste e la grande ospitalità ma apparentemente incompatibile con i rapporti stabili. Eppure il colpo di fulmine con quel Morgan – molto più giovane – in un momento in cui entrambe erano allo sbando, fece prendere alle vite dei due una direzione completamente diversa.
La donna riuscì a far disintossicare il musicista e, restituendogli la sicurezza in sé e facendogli da manager, lo riportò inaspettatamente sulla cresta dell’onda. Morgan invece fece scoprire a Helen un amore che fino a quel momento non credeva possibile, dandole finalmente una ragione di vita.
Questa però è una storia senza lieto fine, e la pellicola, costruita alternando numerose interviste ai musicisti che frequentarono i due a immagini di repertorio e a una rara intervista audio della donna (oggi defunta), ci conduce per mano verso l’epilogo anticipato sin dall’apertura del film: la morte di Lee Morgan alla giovanissima età di 33 anni, in una gelida notte di tempesta del febbraio ’72.
Sembra proprio che certe vite non siano fatte per la stabilità, e il trombettista, nonostante dovesse tutto a quella donna che lo aveva fatto risorgere dalle proprie ceneri, presto si lasciò inebriare dal ritrovato successo e, ingrato come solo gli uomini sanno essere, iniziò a trascurare deliberatamente Helen e a tradirla davanti a tutti gli amici con una ragazza conosciuta durante uno dei suoi concerti.
Helen prima di conoscere Lee aveva avuto una vita difficile e ora, messa dinnanzi a un improvviso nuovo abbandono, sentiva il mondo crollare sotto i suoi piedi. Il teatro della resa dei conti fu lo Slug’s, un club dell’East Village, dove durante una notte di tempesta la moglie si recò per confrontarsi con un ormai sfuggente Lee Morgan. Gli eventi precipitano rapidamente. L’uomo è con l’amante. Nasce un acceso litigio. Anziché fornire giustificazioni, il jazzista umilia la compagna davanti a tutti gli amici e i presenti, spingendola fuori dal locale, per terra, in mezzo a 60 centimetri di neve. La borsetta della donna si apre e il contenuto si rovescia sul freddo manto bianco. Vede la pistola, quella regalatale da Lee per difendersi. Entra furiosa. Un colpo. Due colpi. Non voleva farlo, ma per il trombettista ormai era troppo tardi, e due vite, in modi diversi, erano ormai finite.
Questo il tragico atto finale di un’esistenza tanto intensa da offrire materiale per un documentario appassionato e avvincente, di quelli che ci ricordano la vera anima del jazz.
Scordatevi il fascino retrò e un po’ hipster proposto da Chazelle. Dimenticate totalmente l’aria snob del jazz italiano e quel contesto così ingiustificatamente radical chic. Il jazz è passione, impulso, estremi. Il jazz può essere anche ascesa e caduta. Il jazz può essere anche il contesto ideale per un amore capace di toglierti la vita. Un amore capace di toglierti pure il nome, come face Helen con il marito: “Non mi piaceva il nome Lee, allora decisi che si chiamava Morgan”.

Venezia 73: la recensione di I Called Him Morgan
La carriera e la vita del trombettista jazz Lee Morgan, ucciso dalla moglie a soli 33 anni, in un riuscitissimo documentario presentato fuori concorso.