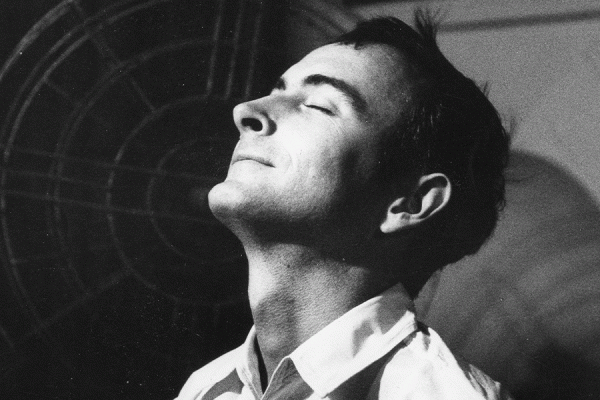“Se si apre in due un insetto si scoprono superfici incredibili” sussurra David Lynch dentro al microfono mentre è seduto dentro una piccola cabina di legno. Lo diceva anche Foster Wallace che mentre a Quentin Tarantino “interessa guardare uno a cui stanno tagliando un orecchio” a David Lynch “interessa l’orecchio”. In fin dei conti lo sguardo di David Lynch è un’esplorazione della materia e dei significati multipli che si nascondono dentro di essa, un’indagine quasi chirurgica che svela costantemente nuove identità deformate e deformabili. Allo stesso modo Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm provano a vivisezionare quello sguardo, in una vera e propria autopsia della vita e della mente del regista: e in buona parte ci riescono, perché il loro David Lynch: The Art of Life, presentato all’ultima Mostra di Venezia e finalmente nelle sale italiane grazie alla Wanted, è capace di raccontare il regista in un modo affatto convenzionale e monolitico, preferendo invece una narrazione stratificata in concetti, visioni e frammenti biografici inediti e preziosi.
Il pre-Lynch
Diciamolo subito: chi si aspetta un documentario accademico e didattico sul cinema di David Lynch rimarrà deluso: qui si racconta un pre-Lynch (o se volete, un post-Lynch), prima ancora artista che autore di film. E’ il Lynch che pazientemente dipinge e monta le sue tele tridimensionali – lavorando il ferro e mescolando i colori – nel suo laboratorio sulle Hollywood Hills mentre vicino a lui gioca l’ultima dei suoi quattro figli (tutti avuti da mogli differenti), la piccola Lula Boginia alla quale è dedicato il documentario. Per buona metà del film vediamo Lynch operare nella materia, lo fa da artigiano creativo con i suoi quadri come lo fa dietro la macchina da presa nel suo cinema. E fra una pausa e l’altra il regista si accende una sigaretta e inizia a raccontare, ad evocare a ricordare. E’ qui che David Lynch: The Art of Life raggiunge la sua massima potenza espressiva, capace di alternare a degli straordinari documenti di repertorio le riprese degli stessi dipinti di Lynch, con quest’ultimi che fungono quasi da punteggiatura visiva e pittorica, come fossero un’espansione narrativa che accompagna il voice-over del regista.
In movimento verso i quadri
Ecco allora che attraverso fotografie e filmati preziosissimi vediamo il Lynch bambino, prima in Montana poi in Idaho e infine in Virginia. Il ritratto affettivo dei suoi genitori e fratelli, i suoi primi disegni e i primi traumatici incontri della sua esistenza, gli stessi che con molta probabilità hanno inevitabilmente segnato anche la sua capacità visionaria. E poi il Lynch adolescente a Philadelphia, il cattivo ragazzo a cui non va giù la scuola e lo studio, quello che beve e che fa corte alla ragazze. Infine il giovane artista, quello che decide di rifugiarsi nello studio del pittore Keeler, vero maestro di arte e di vita, lo stesso che lo incoraggia nella sua convulsa quanto ossessionante ricerca di esprimere quello che sentiva di avere dentro: “sapevo che i miei quadri facevano schifo, ma avevo bisogno di consumarmi, di capire. E l’unico modo era dipingere, dipingere, dipingere per riuscire a catturare qualcosa.”
I quadri che si muovono
L’incontro con il cinema avverrà più tardi, quando Lynch, già marito della sua prima moglie Peggy, padre di Jennifer e con pochissimi soldi in tasca, vedrà muoversi (grazie ad una folata di vento) una tela che sta dipingendo: ecco il passaggio cruciale, la metamorfosi dallo statico al cinetico, la nascita dell’idea del cinema: “e dal dipinto avvertii come una brezza, la vegetazione iniziò a muoversi e pensai: ecco, un dipinto in movimento.” Da lì alla genesi del suo primo corto sperimentale, The Alphabet, il passo è breve. Quella sua prima opera gli procurò una borsa di studio dell’American Film Institute mentre il cortometraggio successivo, The Grandmother, lo portò direttamente a Los Angeles dove, sempre nelle stalle del Film Institute, produsse il suo primo lungometraggio: Eraserhead – La mente che cancella, “la cosa più bella che ho fatto nel cinema”. Da lì in poi Lynch diventerà un’icona e il suo cinema farà la storia della settima arte: ma David Lynch: The Art of Life qua si ferma non va oltre, come a definire un punto di cesura fra il Lynch sperimentale e quello narrativo, fra i quadri in movimento e il movimento dentro i quadri. E forse è davvero così.
Perché è solo a fine visione che capiamo che il cinema, per David Lynch, è stato un bellissimo incidente di percorso di un’artista totale, non previsto né prevedibile. Una deviazione accidentale di un tragitto creativo sempre intenso e vorace che ancora oggi sforna dipinti visionari e onirici dentro a quel vecchio studio da falegname sulle Hollywood Hills. Dopotutto, come ricorda quella voce in voice-over, “l’accidente e la distruzione possono portare a qualcosa di buono.” Non abbiamo dubbi al riguardo: per David Lynch sarebbe stato lo stesso vivere senza incontrare il cinema, ma per noi non sarebbe mai stato lo stesso vivere di cinema senza incontrare quello di David Lynch. Questo è poco, ma sicuro.