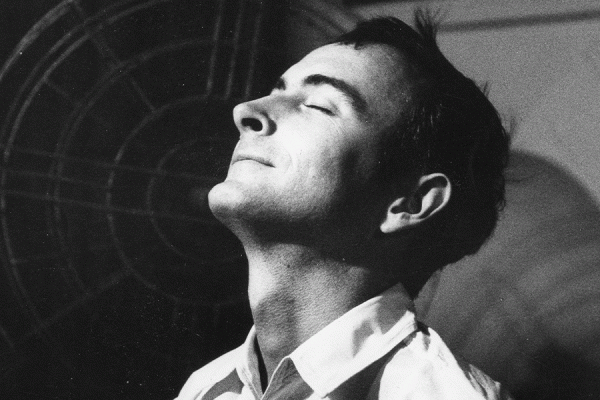In nessun altro posto al mondo esiste un rapporto paragonabile al legame che c’è tra la città di Napoli e Diego Armando Maradona: l’amore incondizionato che il popolo partenopeo prova nei confronti di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi ha dell’incredibile ancora oggi, nonostante siano passati più di venticinque anni dalla sua ultima partita in Serie A. Questo sodalizio indissolubile, che in molti casi trascende il razionale, è il tema centrale di Maradonapoli, il documentario di Alessio Maria Federici che sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 1° maggio per soli dieci giorni.
Maradonapoli racconta questa straordinaria simbiosi dal punto di vista della gente.
A differenza dei soliti documentari dedicati al fuoriclasse argentino, che si focalizzano sulle sue gesta sportive (già Emir Kusturica, nel suo film Maradona, ha cercato di discostarsi dall’approccio tipico lasciando in secondo piano il calciatore e concentrandosi invece sull’uomo), Federici, regista che viene dalla commedia, fa un’analisi sull’impatto sociale, culturale e addirittura economico che hanno avuto i sette anni di Maradona a Napoli. E chi poteva raccontare al meglio questo fenomeno? I napoletani, of course. Il film offre uno spaccato sociologico molto interessante perché, lungo i 75 minuti di durata della pellicola, ad essere intervistate sono persone comuni provenienti da tutte le classi sociali: dal professore universitario al venditore abusivo passando per giornalisti, medici, pensionati, cuochi e preti, la grande passione comune per la figura, quasi mitologica, del Pibe de Oro ha avuto l’effetto formidabile di unire un’intera popolazione. Tanti sono gli aneddoti che si susseguono: dalla presenza di un mercato floridissimo, legale e illegale, di prodotti ispirati alla figura del calciatore (magliette, cuscini, piatti, tazzine, dolci e chi più ne ha più ne metta) alla “confessione” collettiva di aver tifato Argentina nella famosa semifinale dei mondiali Italia ‘90, Italia – Argentina, fino all’aumento smisurato di bambini chiamati dai genitori Diego (in onore del proprio idolo); come se la vita quotidiana in quegli anni girasse letteralmente attorno alla figura dell’argentino. Come si può spiegare una cosa simile? In un periodo di grande difficoltà per la città partenopea (qualche anno prima c’era stato il terremoto in Irpinia, era in corso una guerra di camorra e, nella metà degli anni ‘70, c’era stata addirittura un’epidemia di colera), Maradona rappresentava il riscatto per Napoli; nei panni di un moderno Masaniello, diventò il vero punto di riferimento di una collettività che, rappresentata dalla propria squadra di calcio, riusciva finalmente ad avere la meglio nei confronti di quel Nord quasi sempre vittorioso (nel calcio ma non solo) contro il Sud. Per questo motivo i tifosi saranno eternamente riconoscenti al Pibe de Oro, perdonando la sua discussa condotta extracalcistica (per esempio quando, dopo essere risultato positivo alla cocaina, abbandonò Napoli nel 1991) e venerandolo come se fosse una divinità. Sì, perché Maradona a Napoli si trova sullo stesso piano di San Gennaro: il documentario ci mostra infatti le reliquie, le cappelle votive e le innumerevoli immagini in giro per la città dell’indimenticato numero 10 che lo ergono, mischiando il sacro con il profano, al livello di un dio pagano; la scelta stilistica azzeccata, da parte del regista, di non farci quasi mai vedere nel film il fuoriclasse (ci sono solo pochissime immagini di repertorio) aumenta la sensazione di trovarsi davanti non ad un’entità terrena ma quasi sovrannaturale.
Non è necessario essere degli appassionati di calcio per apprezzare Maradonapoli: il ritmo godibile e le avvincenti storie che vengono raccontate cattureranno immediatamente l’attenzione dello spettatore e rendono giustizia ad un’icona (nel bene e nel male) che non appartiene solo allo sport ma alla cultura popolare.