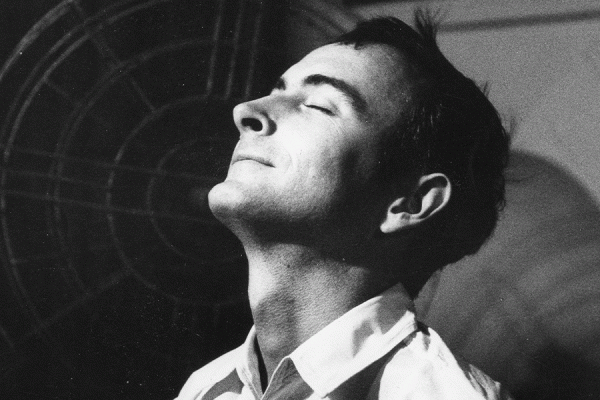Dopo aver fatto scalpore al Sundance lo scorso gennaio, in queste settimane Leaving Neverland ha alzato un polverone mediatico senza precedenti: trasmesso negli Stati Uniti il 3 e 4 marzo, l’ultimo lavoro del regista inglese Dan Reed riapre un capitolo controverso della vita dell’icona del pop Michael Jackson. Attraverso testimonianze inedite il documentario in due episodi co-prodotto da HBO e Channel 4 (che andrà in onda nel nostro paese su Nove il 19 e 20 marzo) getta nuove, inquietanti ombre sulla figura del Re del Pop, arrestato nel 2003 con sette capi di imputazione (tra cui molestie sessuali su minori) ma assolto con formula piena nel 2005 (Jackson era già stato accusato di abusi nel 1993 ma l’azione legale si sviluppò in sede civile, non penale).
A 14 ANNI DALL’ASSOLUZIONE DI MICHAEL JACKSON, DUE TESTIMONIANZE LO RACCONTANO COME UN MOLESTATORE DI BAMBINI
Leaving Neverland è incentrato sulle testimonianze di due presunte vittime di Michael Jackson, James Safechuck e Wade Robson (diventato poi famoso come ballerino e coreografo di Britney Spears e della boy band NSYNC), e dei loro familiari. Safechuck e Robson, che conobbero l’artista nella seconda metà degli anni Ottanta, raccontano la loro versione dei fatti sul rapporto che ebbero con la celebre popstar scomparsa nel 2009, accusando Jackson – che ci ha lasciati 10 anni fa, e ovviamente non può replicare – di ripetuti abusi sessuali perpetrati negli anni.
LEAVING NEVERLAND È NOIOSO NELLA FORMA MA SCIOCCANTE NEI CONTENUTI
Se consideriamo l’opera a livello formale, Leaving Neverland ha la struttura di un canonico documentario per la televisione, che però non lascia nulla sul pavimento dell’editing room e così arriva all’inutile durata monstre di 4 ore, provando non poco lo spettatore. Dan Reed non regala alcun vezzo registico al pubblico puntando sull’essenzialità della forma: infatti, oltre alle interviste ai protagonisti e alle loro famiglie, nel corso del film scorrono numerose immagini di repertorio che mostrano un Michael Jackson inedito. L’obiettivo del documentarista è chiaro: scioccare attraverso il racconto senza filtri di Safechuck e Robson. I due demoliscono l’immagine pubblica di Jacko con ricostruzioni molto intime del rapporto con l’artista, svelando dettagli a luci rosse che potrebbero turbare gli spettatori più sensibili. Reed analizza a 360° gradi la vita dei due accusatori, segnata dall’incontro con il loro ex idolo; inoltre, Leaving Neverland racconta tra le righe senza però alcun intento di denuncia il ruolo che hanno avuto in questa vicenda i genitori di Safechuck e Robson, che sedotti dal fascino magnetico della più grande popstar di sempre e da tutti i vantaggi che venivano da quell’amicizia eccezionale, hanno scelto forse di chiudere gli occhi e consegnare i propri figli a quello che ora dipingono come un carnefice.
NON UN VERO E PROPRIO DOCUMENTARIO, MA UN PROCESSO MEDIATICO CHE NON DÀ SPAZIO ALLA DIFESA
A livello emozionale, Leaving Neverland è un vero e proprio pugno allo stomaco, capace di mettere in difficoltà anche il fan più incallito di Michael Jackson. Se però analizziamo più a fondo il lavoro di Reed, salta subito all’occhio un particolare: il regista non dà mai spazio al contraddittorio. Durante le quattro ore non vengono interpellati né i familiari di Jackson né i suoi legali (la fondazione della popstar ha citato in giudizio la HBO chiedendo 100 milioni di dollari di danni), una scelta alquanto discutibile.
Altra questione che fa storcere il naso è l’attendibilità di Safechuck e, soprattutto, di Wade Robson: il coreografo australiano, oggi principale accusatore del Re del Pop (nel 2014 ha tentato invano una causa civile contro Jackson), è stato infatti uno dei testimoni-chiave (insieme a Macaulay Culkin) che scagionò l’artista nel processo penale del 2005 (anche Safechuck in passato difese Jackson). Robson cerca di spiegare nel documentario le motivazioni che lo spinsero a testimoniare a favore del suo mentore artistico, ma è lecito nutrire dubbi sulla sua versione dei fatti.
L’IMPATTO DEVASTANTE DI LEAVING NEVERLAND SULL’OPINIONE PUBBLICA
Dopo la messa in onda, il documentario di Dan Reed ha avuto un impatto deflagrante: molte stazioni radiofoniche hanno tolto dalle loro rotazioni le canzoni di Michael Jackson, la Fox ha fatto sparire dalla circolazione il primo episodio della terza stagione dei Simpson Papà-zzo Da Legare (in cui Jacko doppia il personaggio di Leon Kompowsky), Louis Vuitton ha annunciato di voler ritirare la collezione ispirata all’artista statunitense e il Museo dei Bambini di Indianapolis ha rimosso alcuni oggetti appartenuti alla popstar.
HBO, con Leaving Neverland, ha messo in piedi un’operazione spregiudicata: se l’obiettivo dei dirigenti del canale via cavo era quello di creare un caso mediatico, hanno ottenuto un grande risultato. Tuttavia una domanda sorge spontanea: a quale prezzo? Quello di distruggere la reputazione di un uomo defunto che non può difendersi e che per la legge non era colpevole? Un documentario non è un’inchiesta giornalistica, questo è vero; ma la potenza persuasiva del cinema e della televisione, mass media in grado di generare miti o mostri, può essere estremamente pericolosa, soprattutto nel momento in cui trasforma l’opinione pubblica in un giudice spietato. Ognuno di noi, dopo la visione del documentario, può trarre le proprie conclusioni. Ma bisogna prendere Leaving Neverland per quello che è: non un processo, non un’inchiesta, ma un film che sostiene una tesi con forza una tesi agghiacciante. Sta allo spettatore confrontare il film con gli esiti processuali e trarre le proprie conclusioni.