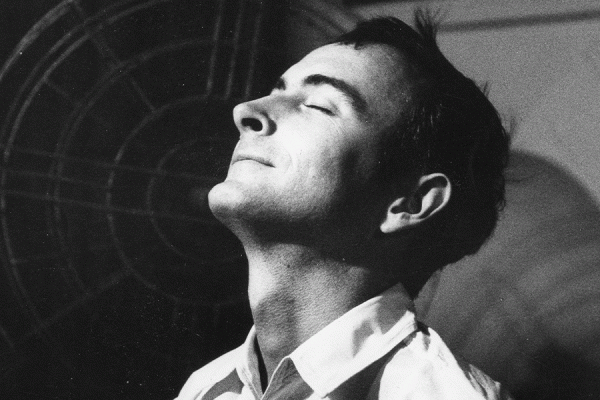(La Writers Guild Italia nasce con l’intento di valorizzare la professione degli sceneggiatori. La sezione “Scritto Da”, sotto l’egida di “Written By”, la prestigiosa rivista della WGAw, tenta di supplire alla grande disattenzione con cui gli scrittori di cinema, tv, e web vengono penalizzati dagli organi di informazione.)
Patrizia Pistagnesi ha scritto con Silvana Mazzocchi il soggetto e la sceneggiatura del documentario Le scandalose, diretto da Gianfranco Giagni e presentato alla Festa del Cinema di Roma nell’ambito della sezione Riflessi.
Cara Patrizia, la nostra piccola sfida iniziale è quella di un pitch. Raccontaci che cos’è Le Scandalose in quattro righe.
Le scandalose narra la storia di una conquista: come le “donne delinquenti”, per dirla con Cesare Lombroso, da streghe, fattucchiere, pazze nel migliore dei casi, abbiano, fra gli altri, portato a casa anche il diritto di essere considerate semplicemente delle criminali. Al pari dei loro padri, fratelli, mariti e amanti.
Avete scelto lo stesso titolo Le scandalose di una trasmissione radio e poi di un libro di Patrizia Carrano. Anche la Carrano metteva al centro storie di donne che avevano dato scandalo, ma lei si è allungata nei millenni e non ha trattato solo assassine. Secondo lei le donne danno scandalo quando si trovano ad esercitare semplicemente la loro libertà. Voi come intendete le donne che meritano il titolo di scandalose?
Le assassine del dopoguerra – Rina Fort, Lidia e Franca Cataldi, Pia Bellentani, Pupetta Maresca – che abbiamo scelto, raccontano nel loro gesto estremo, pur con profonde differenze, anche di un desiderio di vita, di affermazione, di un “vogliamo tutto” che entra in tragico ed estremo conflitto con una ricostruzione in cui, malgrado l’accesso al voto, non cambia molto per le donne. Come testimonia il vasto repertorio d’epoca: una sorta di esilarante commedia all’italiana che narra di un immaginario collettivo, di una società, di una cultura nazionalpopolare in cui la donna continua a oscillare fra l’iconografia di una santa e quella di una puttana. Quotidiani, settimanali e una giovane televisione immortalano indifferentemente dive e assassine secondo quell’antico schema.
In apertura del vostro documentario c’è una frase di Cesare Lombroso che usate come introduzione e – in un certo senso – epitaffio: La donna, mancando spesso di inibizione, trasforma il minimo contrasto in odio. E l’odio in delitto. Ma come? Non viviamo, noi italiani, nel paese dove tutte le donne sono invece sante e mamme?
Ti risponderò con Freda Adler, studiosa di diritto e femminista liberal statunitense, autrice, tra l’altro, di un fondamentale libro purtroppo poco conosciuto in Italia e mai tradotto, “Sisters in crime”, che Silvana e io abbiamo voluto richiamare a chiusura del documentario: “Una corrente ha spazzato via le barriere che proteggevano i privilegi maschili ed eroso le tradizionali differenze che definivano i ruoli di genere. Il fenomeno delle donne criminali è soltanto un’onda nell’ampia corrente dell’emancipazione; un’onda che non è arrivata al suo apice, ma che presto potrebbe raggiungere il picco della violenza maschile… Il meglio e il peggio devono ancora venire e il punto d’arrivo è sconosciuto.” Purtroppo, sembra come minimo anacronistico, ma pare che occorra ancora ripeterlo incessantemente: esistono le persone, Bergman insegna. Tutto il resto, maschile, femminile, santa, puttana, etc. sono aggettivi, o sostantivi aggettivizzati, per così dire. Per quanto mi riguarda, sono sempre più convinta che nel linguaggio, nella parola, si possa rintracciare quello straccio di verità che ci è concesso. Non a caso, nel documentario, del tutto privo del tradizionale commento fuori campo, abbiamo fatto parlare solo le assassine, gli speaker e le firme del giornalismo di quegli anni.
Con Silvana collabori da anni, avete spesso raccontato storie di donne vittime. Perché qui avete voluto raccontare di donne assassine? Sono vittime anche le assassine?
Sarebbe troppo facile rispondere semplicemente sì, così come ogni carnefice è anche vittima, di se stesso, di un contesto, di una storia personale e collettiva. Ma il problema è il passaggio all’atto, quel momento che determina una differenza irrimediabile. Nel caso delle nostre assassine, pur in modo affatto diverso per ognuna di loro, sembra essersi determinato un corto circuito totale con la realtà in cui sono immerse.
È quello che, mi sembra, mostri efficacemente il documentario: il mondo – il repertorio – scorre in un senso che è parallelo e incomunicabile con il desiderio femminile. Come sai, la produzione mediatica sull’argomento è notevole, romanzi, saggi, film, fiction, etc. In molti di questi l’omicidio femminile viene già messo in relazione, illuminato dal contesto socioculturale. Noi abbiamo cercato piuttosto di mostrarne l’aspetto di negazione reciproca, una sorta di perverso rapporto di reciproca esclusione. Almeno fino a un certo momento storico, gli albori di quegli anni settanta sui quali si chiude il documentario.
Avete scelto delle storie ambientate negli anni della guerra e dell’immediato dopoguerra. La seconda guerra mondiale aveva provocato – allontanando gli uomini dalle case – un passo avanti delle donne nella vita sociale, aveva dimostrato la loro autonomia, le aveva inserite in fabbrica… Poi con la fine della guerra le ha chiuse di nuovo in casa. Quanta importanza secondo te ha rappresentato nella vita delle donne questa aspirazione mancata?
Enorme, nel bene e nel male. Voglio dire che, certo, non era semplice andare a lavorare e contemporaneamente magari occuparsi della casa, dei figli piccoli e sopravvivere sotto i bombardamenti. Abbiamo tutti ascoltato le memorie di madri e nonne. Ma proprio per questa drammaticità, per questa eccezionalità, quell’esperienza ha rappresentato un punto di non ritorno: pur assediate da costrizioni di ogni tipo, finalmente la consapevolezza di riuscire a farcela, il sapore della libertà.
Ricorrono nel film, come le pagine bianche che separano i capitoli di un libro, le immagini di corridoi di vecchi carceri e manicomi con le porte delle celle spalancate. Le donne italiane sono ormai fuori dai luoghi dove erano segregate?
È stato un percorso lungo e accidentato, che ha aperto loro infine le porte delle carceri, e chiuso definitivamente alle loro spalle quelle dei manicomi criminali dove le relegava l’infermità mentale, moderna versione della stregoneria di un tempo. Ancora una volta, ci è voluto il corto circuito della seconda guerra mondiale perché quel percorso avesse inizio.
Fate anche un’altra operazione interessante, accostate i singoli crimini alle varie forme di propaganda di modelli femminili ideali, come se l’assassinio sia la rottura, l’esasperazione, una specie di orrida conseguenza del modello stesso. L’esaltazione delle famiglie numerose fa da commento ai sedici figli morti della saponificatrice di Correggio… Pensi che davvero accada questo nella testa delle donne, che l’obbligo diventi orrore?
Non avrei potuto dirlo meglio: è proprio così, l’obbligo diventa orrore. Il perché è comprensibile, lo è meno il come, ancora una volta. Non per tutte, questo accade. Anche se molto spesso la risoluzione di quell’equazione è comunque drammatica: abbandoni, disperazione e solitudine, suicidi. Il problema, credo, allora un’esperienza di poche/pochi, oggi di massa, sia nella questione fondamentale dei nostri tempi, quella che vanno indagando i miei amici psicoanalisti: l’analfabetizzazione emotiva. Non abbiamo più gli strumenti per elaborare le nostre emozioni. Per dirla con un bellissimo libro di Massimo Recalcati, siamo nell’epoca dell’uomo, della persona, dico io, senza inconscio. Quelli, credo, fossero i prodromi, che si dispiegano a nostro avviso con chiarezza, per la prima volta, nella strage familiare compiuta da Doretta Graneris con l’aiuto del suo fidanzato. Il caso che chiude il documentario.
Mi chiedevo come avete lavorato voi sceneggiatrici. Nel doc adoperate come testo della voce narrante, una serie articoli di giornalisti e scrittori importanti… Quindi – lo so, è una provocazione – che avete fatto voi?
Come avrai letto, i testi sono “liberamente tratti da”, pur se con estremo rispetto. In ogni caso, all’inizio, il lavoro è consistito, sulla base dell’idea di Silvana, nell’individuare il filo rosso – il concept – che ci doveva guidare nella ricerca dei materiali originali, testi e immagini. Per secoli, il delitto femminile è stato considerato un’aberrazione più che un atto criminale. Raptus, accesso di follia, acting out isterico, possessione diabolica.
Perfino quando non si trattava di atti efferati, come invece, spesso, si presentavano nella realtà. Le assassine, nell’immaginario collettivo nazionale, almeno fino alla prima metà degli anni Sessanta, sembrano essere vissute più come eredi delle streghe che come le attrici di fatti delinquenziali, dell’atto omicida previsto e punito dalla legge. Atto umano quindi, ma riservato agli uomini, apparentemente. La donna, che dà la vita, la nutre, la preserva, identificata dalla cultura tradizionale con la sua funzione, non può essere concepita come colei che, con violenza, la toglie. Uccidere significa, per lei, perdere le caratteristiche precipue della propria umanità, dimettersi dal consesso umano. Dopo l’affermazione della criminologia e del profiling, e, soprattutto, dopo la profonda trasformazione culturale e legislativa provocata dal femminismo, le donne sono approdate – finalmente, si può dire con un paradosso – al diritto, fra gli altri, di essere considerate delle criminali.
Poi, è iniziato, il lavoro vero e proprio di ricerca, che è la parte più impegnativa dal punto di vista del tempo. Quindi, la rielaborazione senza tradire e la scrittura definitiva, la sceneggiatura.
Chi si è occupato di selezionare le immagini, come avete proceduto, siete stati tutti e tre, voi due e il regista, al montaggio?
Pur nel rispetto delle diverse competenze, è stato un lavoro completamente condiviso nelle sue scelte narrative e stilistiche. Noi abbiamo seguito costantemente il grande lavoro di individuazione e selezione del materiale da parte del regista Gianfranco Giagni, supportato dal personale dell’Istituto Luce. Il regista, con l’aiuto di Luca Onorati, il montatore, ha perfettamente, e creativamente, interpretato l’esigenza di un repertorio e di un montaggio assolutamente dialogici.
Tu ti sei misurata con la scrittura giornalistica e letteraria, la saggistica, la sceneggiatura di film e prodotti televisivi… Tutti generi che oggi sono in crisi, che attendono una rinascita. Ci capita di osservare che molti scrittori si mettono in questa fase a sperimentare la loro creatività – bloccata altrove – con un documentario. Qual è il vantaggio di questo genere? Ne faresti un elogio o è il refugium peccatorum?
Non credo proprio si tratti di un ripiego, dovuto alla rigidità del sistema, per usare un’espressione eufemistica. Del resto i selezionatori dei festival internazionali sono alla perenne caccia di documentari e non mancano certo i riconoscimenti. Penso, invece, che quando non si perde il vizio di scrivere neanche di fronte alle inevitabili alterne vicende di una carriera, alle difficoltà e alle chiusure dell’attuale nostro mercato del lavoro, si rimane anche alla costante ricerca di mettere alla prova la propria creatività e la propria professionalità, di misurarsi con l’attualità e le tendenze future, sia nei contenuti che nei linguaggi, quindi. Inoltre, nell’epoca della contaminazione e della citazione, i formati, per non parlare ormai dei generi, tendono al superamento dei propri confini. Questo accade sia al film di fiction, al documentario, che all’ultima grande serialità statunitense. In ogni caso, l’esperienza del documentario è stata estremamente felice, dal punto di vista della libertà creativa e di tutto il processo di lavorazione. Grazie anche al fatto che, per una volta, c’è un uomo giusto, Roberto Cicutto, al posto giusto. Un vero produttore, un vero uomo di cinema.
La WGI pensa che anche in Italia andrebbe pian piano inserita – così come è avvenuto in tutto il mondo – la figura dello showrunner, con la funzione di garante dell’identità della serie affidata allo scrittore. Credi sia possibile?
Cara Giovanna, sai che sono completamente d’accordo con la vostra posizione, e credo che, anche al cinema, lo sceneggiatore debba avere il ruolo di executive producer nel corso della lavorazione del film. Detto questo, malgrado le ottimistiche dichiarazioni pubbliche e qualche esperienza di alcuni miei colleghi, credo che siamo ancora lontanissimi dal far accettare una rivoluzione simile. Non solo a causa della rigidità del sistema di cui si diceva prima, ma, come al solito, per la resistenza culturale, direi ideologica, per cui, a cominciare dai diretti interessati, l’autore in Italia, e anche in Europa, è solo il regista. Questo è dovuto a tutta una storia lunga e complessa che non possiamo certo affrontare qui.
La legge cinema è stata appena approvata in Senato e deve riprendere il suo cammino alla Camera. Come sai, il nuovo sistema rende difficile la sopravvivenza delle piccole produzioni e tende a concentrare tutto il denaro utile nelle mani di pochi: per sfidare il mercato internazionale, si dice. Ci credi? Sei d’accordo?
Assolutamente no. Credo che la mission sarebbe dovuta essere proprio l’opposto. Del resto è una legge economica generale di cui sono convinta: il mercato va regolato non assecondato, anche quello dell’audiovisivo.
Nello stesso tempo si consolida l’alleanza tra tv e cinema (vedi l’ingresso di Sky nella distribuzione…) Anni fa, proprio la tv è stata accusata della crisi del cinema. Adesso, ti sembra che sia cambiato qualcosa?
E’ una domanda cui per rispondere non basterebbero dieci pagine! Se dico che sì, è cambiato, ma paradossalmente in peggio, come al solito tutti mi attaccheranno o, gli amici, diranno che è una provocazione… Per ora ti dico solo che, di fondo, il problema è sempre la rigidità del sistema, quasi monopolistico, anche se si associano, i soggetti sono sempre gli stessi, la sua chiusura, la autoreferenzialità, il familismo, i salotti buoni, etc. Del resto, sono i problemi del sistema Italia, e l’audiovisivo non è un universo autonomo…
La Rai è stata dichiarata PA dall’Istat e sembra una scelta rischiosa, che può tagliarla fuori dal mercato. Paura ingiustificata?
Da un lato. Paura di sottostare finalmente alle regole, una paura tipicamente italiana anche questa. Dall’altro, è vero che, se il sistema fosse sano, la Rai dovrebbe avere uno statuto speciale, occupandosi di produrre cultura.
(intervista a cura di Giovanna Koch)